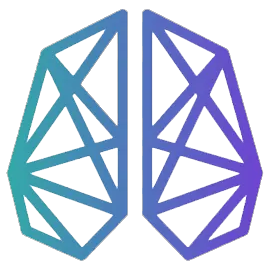Per noi il linguaggio è un calcolo; esso è caratterizzato dalle azioni linguistiche
Ludwig Wittgenstein
I teorici degli “atti linguistici”, come John Austin (1911-1960), John Searle, Paul Grice (1913-1918) e Ludwig Wittgenstein (1889-1951) spostarono l’attenzione della filosofia del linguaggio dallo “studio del significato delle parole” all’uso che ne facciamo.
Questo cambio di prospettiva venne inaugurato da Austin, stanco che il linguaggio venisse analizzato solo da una prospettiva logica, che iniziò a studiare come l’uso di un’espressione linguistica (ad esempio un comando o un’espressione di desiderio) provochi un tipo di azione. Austin nell’opera “Come fare cose con le parole” (1962) si dedica quindi ad analizzare e a delineare le “intenzioni” di chi produce atti linguistici, ma anche a sostenere che “dire qualcosa” equivalga a “fare qualcosa”.
Austin distinse tre generi di atti linguistici:
• Locutivo
• Illocutivo
• Perlocutivo
La prima opera “Atti linguistici” (1969) di Searle venne molto influenzata da Austin, ma il suo scopo primario era di fornire una tassonomia generale degli atti linguistici:
• Enunciativi,
• Proposizionali
• Illocutivi
• Perlocutivi
Se il contenuto proposizionale è lo stesso (“Andrés beve la birra abitualmente”) la forza potrebbe differire in base al background, a seconda se una frase è un’affermazione, una domanda (“Andrés beve la birra abitualmente?”), un ordine o l’espressione di un desiderio (“Vorrei che Andrés bevesse la birra abitualmente”).Da questo ultimo punto risulta chiaro che per Searle un atto illocutorio sia un “atto comunicativo intenzionale”.
L’intenzionalità dell’azione
Iniziamo a notare come Searle dalla teoria degli “atti linguistici” perviene al concetto di “intenzione”, che sarebbe cruciale per la descrizione di un “atto”, in quanto si riferirebbe sempre alle “intenzioni” del parlante.
Searle giunge quindi ad analizzare l’intenzionalità dell’azione di un parlante, ricavando in essa una “direzione d’adattamento” e una “direzione di causa”:
• La prima è focalizzata sul rapporto mondo-mente
• La seconda è focalizzata sul rapporto mente-mondo
Ad esempio, quando raccogliamo un fiore, la nostra intenzione sarebbe quella di adattare il mondo al nostro stato mentale ed ecco perché avremo una direzione d’adattamento mondo-mente. Al contrario quando vediamo un fiore, il nostro stato mentale è disposto per esser “adattato” allo stato del mondo e avremmo quindi una “direzione d’adattamento” mente-mondo.
Searle giunge quindi all’intenzionalità attraverso lo studio degli atti linguistici.
Nell’opera “Dell’intenzionalità” (1983) rielabora la tradizione fenomenologica di Franz Brentano (1838-1917) e di Edmund Husserl (1859-1938) in una prospettiva “realista”, prendendo cioè le distanze dallo psicologismo di Brentano e dal trascendentalismo di Husserl. Dal primo filosofo, Searle riprende il carattere “irriducibile” dell’intenzionalità e del secondo condivide invece l’idea che sia un “evento della coscienza”.
Se per Brentano gli oggetti a cui verte la coscienza erano psichici e per Husserl gli “atti della coscienza”, per Searle nella sua visione “realista” sono invece gli oggetti stessi del mondo:
l’intenzione è diretta verso un oggetto fisico che esiste realmente e non è solo contenuto nella nostra mente
L’intenzionalità sarebbe quindi per Searle una proprietà “intrinseca” e “irriducibile” della nostra mente e andrebbe considerata come un ‘fenomeno primitivo’ in base alla quale analizzare i problemi inerenti alle espressioni di desiderio, all’azione e alla causalità.
Fenomeni primitivi che vengono paragonati da Searle a quelli biologici come la fotosintesi, la mitosi e la digestione. Questo paragone sarebbe alla base della soluzione proposta da Searle sul dibattito “mente-corpo” che chiama “naturalismo biologico”, definendo così la coscienza come “una proprietà mentale e quindi fisica del cervello”. Inoltre Searle fa una distinzione fra intenzionalità intrinseca e derivata e quest’ultima non sarebbe altro che “l’atteggiamento proposizionale” di Bertrand Russell e “l’atteggiamento intenzionale” di Daniel Dennett. Risulta così evidente il contrasto tra i due filosofi che prenderà ancora più forma nell’argomento della stanza cinese, addotto da Searle a sostegno della sua teoria dell’irriducibilità del mentale al fisico.
La coscienza
L’indagine sull’intenzionalità e la coscienza non potevano che condurre Searle ad attaccare l’intelligenza artificiale forte, posizione critica che verrà esposta in “Mente, cervelli e programmi” (1984). Searle, attraverso il famoso esperimento mentale della stanza cinese, dimostra che le macchine sono solo in grado di manipolare i simboli (sintassi), ma non sono in grado di interpretarli (semantica) e quindi di produrre significato.
L’indagine di Searle sull’intenzionalità non poteva che ampliarsi in una teoria della coscienza esposta nell’opera “La riscoperta della mente” (1992) in cui riassume il suo naturalismo biologico in quattro tesi:
- Gli stati coscienti soggettivi quelli in “prima persona” sono fenomeni reali del mondo reale. Non possiamo pervenire ad una riduzione eliminativista della coscienza (come Dennett), perché tale riduzione (in “terza persona” ) lascerebbe insoluta l’ontologia del soggetto.
- Gli stati coscienti sono causati interamente dai processi neuro-biologici cerebrali di livello inferiore. Essi sono perciò causalmente riducibili ai processi neurobiologici. Non hanno vita autonoma. In termini
causali non sono qualcosa che va al di là dei processi neurobiologici. - Gli stati coscienti sono realizzati nel cervello quali caratteristiche del sistema cerebrale, e dunque
esistono a un livello più alto di quello dei neuroni e delle sinapsi. I singoli neuroni non sono coscienti,
ma sono coscienti specifiche parti del sistema cerebrale costituite dai neuroni. - Gli stati coscienti, essendo caratteristiche reali del mondo reale, hanno efficacia causale.