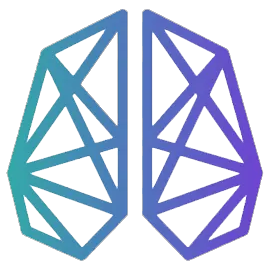La confusione che le persone provano nei confronti della morte cerebrale riflette secoli di confusione filosofica e medica su come definire la morte.
Quando ancora non si era in grado di misurare l’attività del cervello con le attuali tecniche di neuro-imaging il trapasso veniva identificato con il fermarsi del battito cardiaco. Anche se in realtà il cervello sopravviveva dai sei ai dieci minuti dopo che il cuore aveva smesso di pompargli il sangue, ma questo è solo un dettaglio, ed il criterio di morte impiegato funzionava abbastanza bene.
Il problema è che per secoli i medici non sono stati in grado di dire con esattezza , se il cuore aveva smesso di battere, o se erano loro che avevano difficoltà nel sentirlo.
Nel libro “Stecchiti, le vite curiose dei cadaveri” la giornalista scientifica Mary Roach ci racconta come nel 700-800 i medici, per placare le paure dei pazienti di essere sepolti vivi ma anche i propri timori, idearono una serie di procedure di prova per stabilire se la morte era avvenuta:
- tagliare le piante dei piedi
- fanfare di ottoni nelle orecchie
- tirare i capezzoli con le pinze
- clistere di tabacco
- campana sul pollice
Metodi che vennero ben presto sostituiti dalla più funzionale osservazione della putrefazione del corpo in obitorio.Con l’invenzione e perfezionamento dello stetoscopio ed i progressi nella conoscenza medica, i medici iniziarono a convincersi di poter loro stessi sentenziare quando un cuore aveva smesso di battere.
Morire dopo Harvard
Our primary purpose is to define irreversible coma as a new criterion for death. There are two reasons why there is need for a definition:
(1) Improvements in resuscitative and supportive measures have led to increased efforts to save those who are desperately injured. Sometimes these efforts have only partial success so that the result is an individual whose heart continues to beat but whose brain is irreversibly damaged. The burden is great on patients who suffer permanent loss of intellect, on their families, on the hospitals, and on those in need of hospital beds already occupied by these comatose patients.
(2) Obsolete criteria for the definition of death can lead to controversy in obtaining organs for transplantation.
Il 5 agosto del 1968, il “Journal of American Medical Association” pubblicò il rapporto di Harvard, che fissò il momento della morte non più nell’arresto cardiaco, ma nella cessazione totale delle funzioni del cervello. In accordo con questa definizione, i medici adottano attualmente altri criteri clinici come test che valutano la respirazione abbinati a test strumentali come l’ elettroencefalogramma (EEG), che misura due volte in sei ore l’ attività del cervello prima di decretarne la morte.
In qualche caso si ricorre anche a indagini come l’ angiografia; si inietta un liquido di contrasto nella circolazione sanguigna: in caso di morte cerebrale i vasi sanguigni non si colorano, il che significa che il sangue non arriva al cervello e che quest’ultimo è in necrosi.
Questo cambio di paradigma era dovuto ai progressi in ambito tecnico-scientifico e medico che permettevano di rianimare il cuore e di avere misurazioni più precise per rilevare la perdita di funzioni cerebrali.
La ridefinizione di morte venne accettata rapidamente perché non venne letta come un radicale cambiamento del concetto di morte, ma soltanto come una conseguenza del processo tecnologico
Lo stesso anno, il filosofo tedesco-americano Hans Jonas si oppose a questa definizione sostenendo che era dettata solo da esigenze pratiche, quelle stesse menzionate dal rapporto di Harvard: liberare pazienti, congiunti, e risorse mediche dal peso di un coma indefinitamente protratto ed evitare controversie riguardo l’ottenimento di organi per trapianto.
Il rapporto di Harvard, nonostante le critiche di Jonas, divenne lo spartiacque medico e legale tra la vita e la morte e tutti i paesi del mondo si adeguarono rapidamente a questo criterio. Ed anche la Chiesa cattolica si allineò. In particolare con una dichiarazione del 1985 della Pontificia Accademia delle Scienze e poi ancora nel 1989 con un nuovo atto della stessa accademia, avvalorato da un discorso di Giovanni Paolo II.
Il Papa tornò ancora sul tema in successive occasioni, ad esempio con un discorso al congresso mondiale della Transplantation Society, il 29 agosto del 2000. Anche se in un editoriale del 3 settembre 2008 l’Osservatore romano, la giornalista Lucetta Scaraffia dichiarava che la morte cerebrale non può sancire la fine di una vita perché l’idea che la persona umana cessi di esistere quando il cervello non funziona più, mentre il suo organismo (grazie alla respirazione artificiale) è mantenuto in vita, comporta una identificazione della persona con le sole attività cerebrali, e questo entra in contraddizione con il concetto di persona secondo la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma persistente.
Poco dopo arrivò una nota della Sala Stampa vaticana in cui si precisava che “un articolo non cambia la dottrina: si tratta di un editoriale dell’Osservatore Romano, firmato da una persona e che porta l’autorevolezza della testata e di quella persona”.
Accettando il rapporto di Harvard, la chiesa cattolica si proclamava anche favorevole al prelievo degli organi da pazienti di cui si é accertato il coma irreversibile, nonostante ancora respiri e il cuore batta.
La sede e il peso dell’anima
Con il rapporto di Harvard mettere il cervello, e non il cuore o il fegato come per gli antichi, al centro della definizione di morte servì di riflesso a farne il protagonista della definizione di vita, di anima e di coscienza.
Ogni contesto storico-culturale ha quindi sviluppato la sua personale filosofia della mente e del corpo, in greco le due sostanze vennero chiamate psiche e soma, in latino da Cartesio res cogitans e res extensa, ma oggi più prosaicamente le definiamo mente e materia, la prima studiata dalla fisica e la seconda dalla psicologia.
Nella terminologia religiosa, scientifica e filosofica si usano variazioni sul tema come: anima, spirito (spiritus), coscienza, sé , intelletto (intellectus) , e ragione (ratio). Con l’avvento dell’intelligenza artificiale arriviamo a paragonare la mente ad un software ed il corpo al hardware. In origine lo spiritus latino, come i suoi sinonimi greci psiche e pneuma, o quelli sanscriti brahman e atman, non significavano altro che la naturale respirazione, nelle due forme dell’inspirazione e dell’espirazione.
Nel Fedone di Platone assistiamo ad un passaggio successivo, alla nascita dell’identità personale come concentrazione dell’anima “che partendo da tutti i punti del corpo in cui è dispersa, si raccoglie pura in se stessa, sciolta dal corpo come da catene”.
L’attaccamento dell’anima a un corpo è solo la dimostrazione della natura atemporale della prima sostanza e della mortalità del corpo. Invece oggi sappiamo, come ci ricorda il Prof. Giovanni Berlucchi in questa intervista, che può esistere un cervello funzionalmente attivo senza coscienza, ma non esistere una coscienza senza un cervello. E se la morte cerebrale è la definizione legale di morte, dove risiede l’anima immortale? Come individuare il momento esatto in cui l’anima esce e quel che rimane è un cadavere? Se soltanto si potesse misurare quell’attimo , allora si la morte sarebbe solo una questione di osservazione scientifica.Come il rudimentale tentativo del medico Duncan Macdougall che nel 1907 misurando il peso di sei pazienti ,prima o dopo la morte, aveva dedotto che i 21 grammi di differenza erano l’anima. Come ulteriore conferma della sua scoperta riscontrò che in 15 cani moribondi non vi era un cambio significativo di peso.
D’altronde già Cartesio aveva sentenziato che gli animali erano privi di un’anima.
Il problema della relazione tra mente e materia, che Cartesio non seppe risolvere, è sempre rimasta come sfondo per le discussioni coinvolgendo lo psicologo per la psiche, lo scienziato per la mente e sconvolgendo il teologo.
Trapiantiamo il cervello
Gli occhi seguivano i movimenti delle persone e degli oggetti che entravano nel campo visivo, e le teste rimasero sostanzialmente battagliere nei loro atteggiamenti come dimostrarono i morsi in reazione a stimoli orali
Ora sappiamo che possiamo avere un cervello senza coscienza e non il contrario, ma se trapiantassimo il cervello?
A metà degli anni sessanta, il neurochirurgo Robert J. White cominciò a fare degli esperimenti su preparazioni cerebrali isolate, cioè nel prelevare un cervello vivo da un animale e collegarlo alla circolazione di un altro corpo.
L’esperimento più noto e con esito positivo fu lo scambio delle teste di due scimmie che erano state etichettate come A e B, alla fine la testa di A era attaccata al corpo di B che però non aveva il controllo del corpo perché il midollo spinale era stato reciso a livello del collo. La scimmia B sopravvisse una sola settimana.
Venti anni prima, era stato eseguito un analogo esperimento dal neurochirurgo russo Vladimir Demikhov che trapiantò venti teste (in realtà anche polmoni, zampe anteriori) di cuccioli su cani adulti, per osservarne la durata della sopravvivenza.
La speranza di Robert J. White era il trapianto di una testa umana con l’intento di aiutare i pazienti tetraplegici donandogli l’intero corpo, gli esperimenti non avvennero mai sull’uomo e furono interrotti agli inizi degli anni novanta. White comprese che, raffreddando il cervello durante l’operazione in modo da rallentare il processo di deterioramento delle cellule (stessa tecnica usata per i trapianti di organi), sarebbe stato possibile conservare la maggior parte delle funzioni.
Questo significa che la personalità, la psiche, l’anima di quelle scimmie rimaneva inalterata anche se all’interno di un altro animale? Secondo questo controverso neurochirurgo, che fu anche consulente scientifico di papa Giovanni Paolo, il trapianto di testa, oltre che essere fattibile, non recherebbe danni all’intrinseca individualità, alla personalità, alla struttura emotiva, all’intelligenza e alla memoria.
Per il premio Nobel per la medicina Jean Dausset, il trapianto prospettato da White, non solo esprimerebbe forti perplessità bioetiche, ma anche tecnico-scientifiche perché ci sono numerose sostanze generate dal corpo che influiscono sul funzionamento del cervello e quindi sull’identità della persona. Della stessa opinione è il neurobiologo Steven Rose che afferma
La persona che siamo è senza dubbio nel cervello, ma non solo nel cervello. La coscienza è dunque l’insieme del corpo e del sistema nervoso. Non possiamo negare l’unità anatomo funzionale del corpo con la testa, cioè che l’encefalo (contenuto nella scatola cranica, ovvero la testa ) e il midollo spinale (contenuto nel canale della colonna vertebrale, ovvero nel corpo) fanno parte del sistema nervoso centrale.
Sappiamo che la coscienza è un prodotto del cervello anche se non sappiamo esattamente come sia possibile. Ora si tratta di stabilire se si è coscienti solo in presenza di attività cerebrale ed implicitamente autorizzare il distacco della spina ai pazienti in stato vegetativo. Se, invece, si ammette che la coscienza è disgiunta dalle misurazioni neurofisiologiche, bisognerebbe trovare un nuovo confine che separi la vita dalla morte.
Ricordandoci, quanto sostenuto in questo articolo “You won’t find consciusness in the brain”dal medico Raymond Tallis, che lo scontro accademico tra i due schieramenti, tra chi ritiene possibile spiegare la coscienza attraverso l’osservazione dell’attività cerebrale e chi contesta questa tesi , sia dannoso soprattutto per i pazienti in stato vegetativo.